Anno Accademico 2015-2016
Vol. 60, n° 3, Luglio - Settembre 2016
Tavola Rotonda: Assistenza Sanitaria per intensita’ di cura. Un ‘work in progress’ permanente?
03 maggio 2016
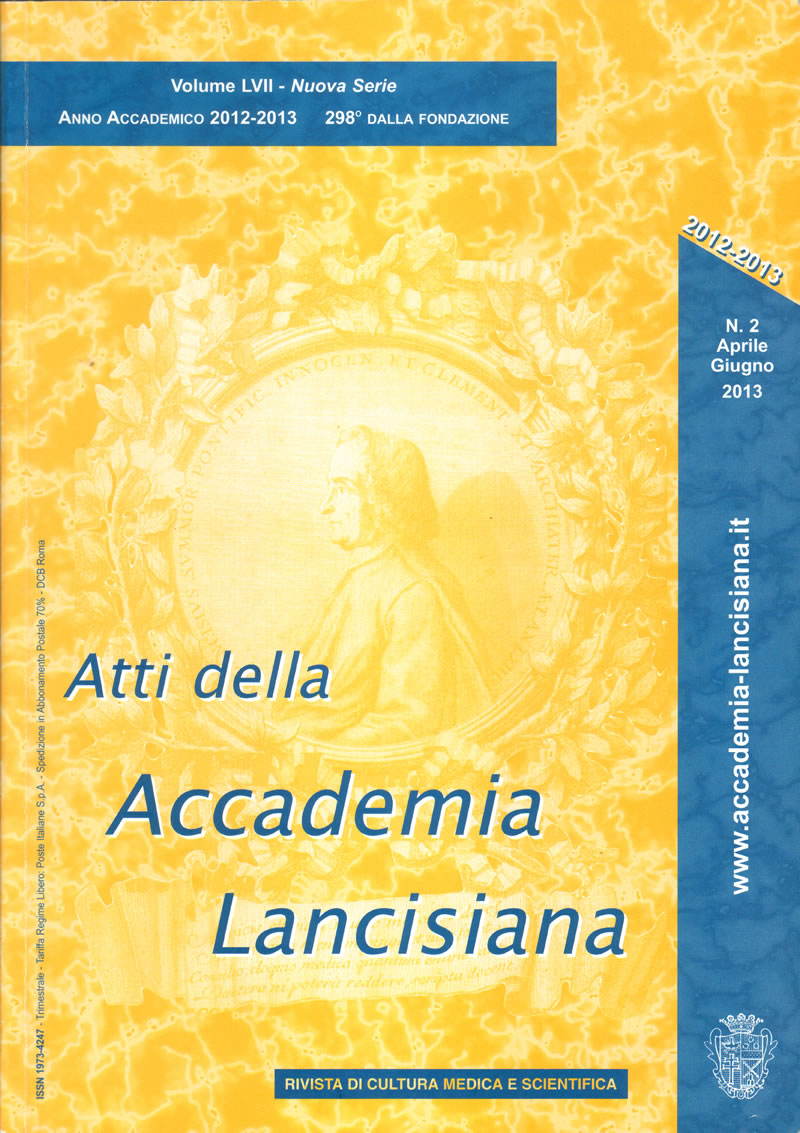
Tavola Rotonda: Assistenza Sanitaria per intensita’ di cura. Un ‘work in progress’ permanente?
03 maggio 2016
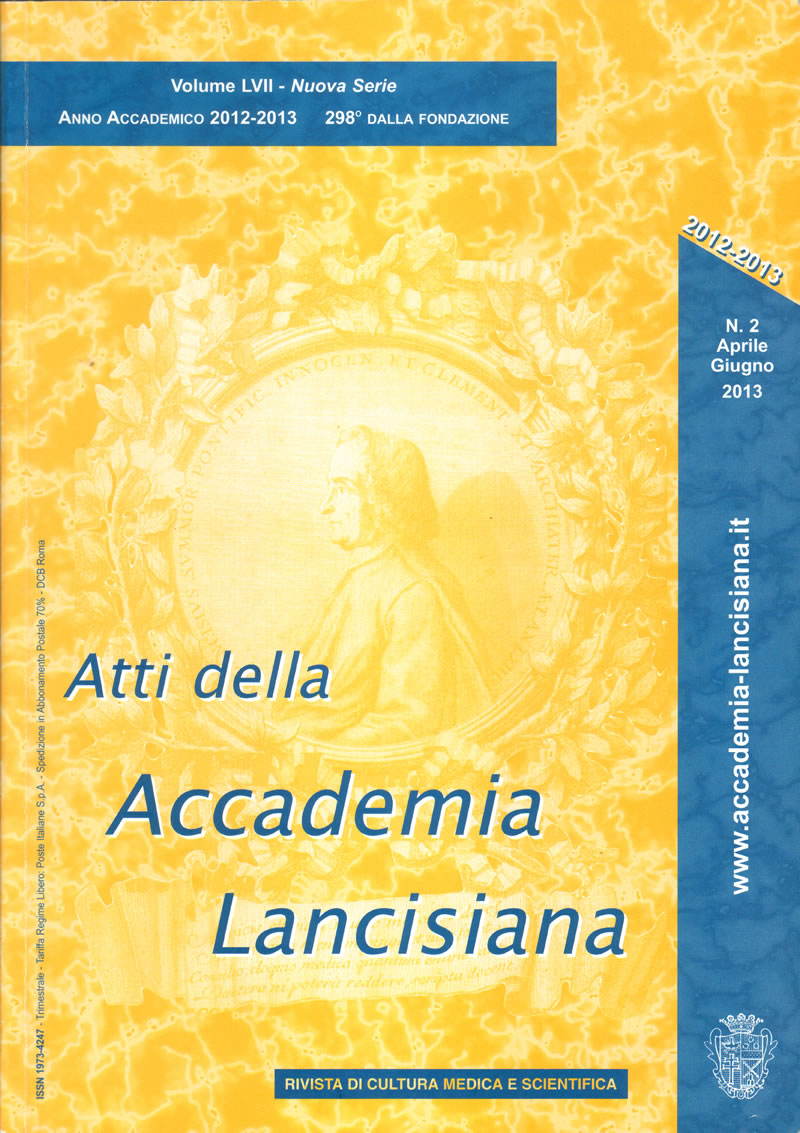
Versione PDF dell'articolo: Download
Presentazione dott.ssa Laura Gasbarrone
La prima affermazione della necessità di una “nuova organizzazione dei letti in ospedale in base al principio della intensità assistenziale” risale a Raven che la pubblicò sul British Medical Journal nel 1962, ben 54 anni fa. Dovremmo in teoria dare per acquisito l’argomento, ma la realtà dei fatti è ben diversa, anche se ormai tutti i piani regionali e i relativi regolamenti attuativi danno precise indicazioni al superamento dei reparti di ricovero per specialità mediante una organizzazione articolata per aree omogenee di complessità assistenziale, che vede al centro il paziente secondo un approccio multidisciplinare integrato.
In questa tavola rotonda cercheremo di entrare nella realtà di questi quattro contesti assistenziali diversi e discutere l’argomento con i rispettivi Direttori Generali e poi con gli intervenuti in sala, cercando di mettere in evidenza aspetti, problemi o criticità di questa nuova organizzazione:
- Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, Azienda Ospedaliera di alta specializzazione, DEA di II livello, HUB per parecchie patologie, ospedale di riferimento per l’Università Sapienza, che non comprende il territorio, il cui Direttore Generale è il dott. Domenico Alessio, rappresentato qui questa sera dal Direttore Sanitario dott. Ferdinando Romano;
- Azienda Sanitaria Locale Viterbo, nel contesto di una provincia del Lazio, con strutture ospedaliere con DEA di I livello, postazioni di primo soccorso, strutture del territorio, di cui è Direttore Generale la dott.ssa Daniela Donetti;
- Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, Azienda di alta specializzazione, DEA di II livello, HUB per parecchie patologie, che non comprende il territorio, il cui Direttore Generale è il dott. Antonio D’Urso;
- Azienda Sanitaria Locale Roma 1, nata recentemente dalla fusione tra la ASL Roma B e la ASL Roma E, Azienda Sanitaria con ospedali con DEA di I livello e strutture territoriali, di cui è Commissario Straordinario il dott. Angelo Tanese.
Nella seconda parte della serata sentiremo l’esperienza della dott.ssa Flori Degrassi, Commissario Straordinario della ASL Roma 2, anche quest’ultima nata di recente dalla fusione della ex ASL Roma B con la ASL Roma C, con ospedali con DEA di I livello e strutture territoriali. La dott.ssa Degrassi è stata fino a pochi mesi fa Direttore Regionale dell’Area Salute e Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio, quindi dal lato di chi pensa alla organizzazione sanitaria, ma tra i suoi numerosi incarichi precedenti ha ricoperto dal 2005 al 2010 il ruolo di Direttore Generale della ex ASL Roma B, ora confluita nella Roma 2, applicando già allora il modello per intensità di cure.
Condurrà la serata il dott. Antonino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze), che ha acquisito un ruolo sempre più attivo e propositivo nella discussione dei problemi in sanità e che ha tenuto quest’anno la Prolusione nella seduta inaugurale di questa Accademia.
Tavola rotonda
Introduzione del Dott. Nino Cartabellotta
In Italia quando si parla di “intensità di cura” ci si riferisce quasi sempre all’assistenza ospedaliera, quindi si parla correntemente di “ospedale per intensità di cura”; in realtà il concetto non si esaurisce qui ma continua anche nel territorio; una delle maggiori difficoltà per l’implementazione del modello è costituita dalla mancanza di strutture territoriali intermedie che idealmente dovrebbero permettere quindi una graduazione decrescente della assistenza dai livelli più elevati di assistenza di competenza dell’ospedale (terapia intensiva), a quelli meno elevati della assistenza di competenza territoriale fino al domicilio del paziente.
Si tratta quindi di un modo diverso di vedere l’assistenza ospedaliera: la classica organizzazione per unità operative basata sulla disciplina è sostituita da un’organizzazione per aree omogenee di complessità assistenziale; è un modello che definisce un nuovo paradigma del concetto di cura, molto tecnologico, in cui si separano le componenti squisitamente clinico-operative da quelle organizzative e da quelle che vengono chiamate le cosiddette piattaforme produttive (ambulatori, reparti, camere operatorie, etc.), solitamente delegate ad una organizzazione dipartimentale per garantire maggiori produttività, economia e flessibilità. E’ quindi prevista una suddivisione dei posti letto in aree funzionali di tipo medico e chirurgico con letti “funzionali”, flessibili e dinamici a seconda delle esigenze specifiche dei pazienti, con una gestione clinico-organizzativa secondo processi.
Quindi da un modello organizzativo verticale, costituito da reparti monospecialistici, si passa ad una gestione di tipo orizzontale, con un modello diverso anche dal punto di vista strutturale, fatto di piattaforme ambulatoriali, aree di degenza, di terapia intensiva, sale operatorie, applicabile sia all’area medica che all’area chirurgica. Dal punto di vista strutturale, il paziente che arriva in Pronto Soccorso, grazie a una serie di strumenti standardizzati preposti a valutare sia la instabilità clinica sia la complessità assistenziale, dovrebbe essere collocato nell’area idonea a garantire il giusto livello assistenziale, (alta o media intensità); il livello a bassa intensità dovrebbe essere prerogativa del territorio, sia per quanto riguarda l’assistenza domiciliare che la degenza in strutture di tipo intermedio.
Premesso che, nonostante l’applicazione del modello sia abbastanza diffusa in molti ospedali italiani, abbiamo pochissime evidenze pubblicate in letteratura, proporrei ai nostri ospiti un primo giro di opinione:
1. Esistono ancora evidenze limitate sui reali benefici dell’ospedale per intensità di cura: quali potenziali vantaggi in termini di qualità della assistenza, recupero di inefficienze/sprechi ed esperienze dei pazienti?
Dott. Angelo Tanese: il tema è in una fase di elaborazione anche in questa Azienda Sanitaria, quindi anche io non ho evidenze da portare. Va detto che generalmente siamo troppo poco abituati a valutare le modifiche organizzative e tendiamo a ragionare per modelli e meno in termini di evidenze. La mia valutazione è che certamente un ospedale così concepito privilegia l’attenzione al paziente, è più orientato sulla gestione del percorso che sull’offerta della singola struttura, più centrato sulla domanda e meno centrato sull’offerta; dall’altra parte è un sistema che può generare maggiori efficienze all’interno della gestione dei posti letto. In assoluto quindi vedo più vantaggi che svantaggi, e ritengo un alibi dire che le cose non si possono cambiare: è ormai il momento di superare i vecchi paradigmi e i vecchi schemi della gestione dei posti letto. In alcune realtà ci sono evidenze che efficienza e attenzione al paziente, senza sbilanciare il percorso, siano motivi sufficientemente validi per andare in questa direzione.
Dott. Antonino Cartabellotta: al dott. Antonio D’Urso pongo la stessa domanda, facendo anche un’altra considerazione: le innovazioni in generale, non solo in sanità, possono essere distinte in innovazioni di prodotto, di processo o di rottura; l’ospedale per intensità di cura è considerata generalmente una innovazione di processo. E’ corretta questa valutazione, o l’ospedale per intensità di cura deve essere piuttosto interpretato come innovazione di rottura?
Dott. Antonio D’Urso: a giudicare dalla resistenza che si incontra da Nord a Sud nel cercare di applicare il modello per intensità di cura, direi che sicuramente si tratta di una innovazione di rottura. Le evidenze ci sono, ma sono difficilmente confrontabili, perché il modello per intensità di cura non è un dogma: il modello è una filosofia, non è fatto da una serie di comandamenti, per cui confrontare ospedali che adottano il modello è veramente difficile: all’ospedale Pertini di Roma o in Toscana non si fa nello stesso modo, per cui confrontare ospedali che adottano comportamenti simili è obiettivamente più complesso rispetto alla applicazione di un protocollo che deve seguire rigidi schemi di terapia. La seconda considerazione che faccio è che in Toscana, ad esempio a Lucca dove sono stato, ci sono ospedali anche interamente organizzati per intensità di cura; mi piacerebbe anche ragionare togliendo la dizione “per intensità di cura” perché ritengo che generi una immediata resistenza da parte di molti con il risultato che tutto quel che si dice dopo viene percepito negativamente. In realtà in molte situazioni noi medici siamo già abituati all’ospedale per intensità di cura anche se non lo chiamiamo così: ad esempio tutti i chirurghi che lavorano nel privato in attività libero-professionale sicuramente ricoverano il paziente il giorno stesso dell’intervento, sicuramente lo avviano ad una pre-ospedalizzazione centralizzata dove il paziente fa tutti gli esami propedeutici in un unico giorno, sicuramente la durata della degenza sarà ridotta molto in funzione del decorso clinico, nessuno si ricovera in casa di cura privata il sabato pomeriggio per essere operato il lunedì mattina. Quindi abolizione della degenza pre-operatoria, pre-ospedalizzazione centralizzata, chirurgia elettiva, distinzione in week e long surgery sono tutti principi della intensità di cura. Più difficile è l’applicazione in area medica. Ci sono anche strutture ospedaliere private organizzate secondo questo modello, come l’Humanitas di Milano, nato dalla mente dell’industriale Rocca: oggi non possiamo pensare che i vecchi modelli di ospedale dettati dalla legge Petragnani del 1968 con divisione in reparti e servizi possano rispondere alle esigenze odierne: così come sono cambiate nel tempo le terapie devono cambiare anche le organizzazioni sanitarie. Negli ospedali dove il modello è stato applicato ci sono grandi forme di efficientamento e di miglioramento di outcome e di efficacia, ma deve essere rispettato il presupposto della disponibilità di tutti i professionisti a voler applicare il cambiamento.
Dott.ssa Daniela Donetti: sono d’accordo con Antonio D’Urso che il cambiamento rappresenti una innovazione di rottura, ma a mio avviso è anche una innovazione di processo. E’ una innovazione di rottura perché modifica radicalmente la struttura organizzativa della azienda, centrando l’assistenza sulle esigenze dettate dalla clinica del paziente, ma contemporaneamente comporta la necessità di rivedere in modo radicale gli strumenti che dobbiamo adottare per applicarlo, quindi è anche una innovazione di processo. Intanto è necessaria una attività iniziale di progettazione e di programmazione molto seria che coinvolge tutti gli operatori che devono condividere tutti gli strumenti del progetto. I vantaggi sono visibili nella gestione clinica dei pazienti, in termini di qualità della assistenza con gli strumenti che si adottano, quali l’approccio multidimensionale alle problematiche cliniche, l’audit; ma ci sono anche vantaggi economici perché nel momento in cui si riorganizzano le aree e le piattaforme tecnologiche e se ne fa un uso flessibile e condiviso c’è un evidente vantaggio economico. Nel momento in cui si affronta un cambiamento culturale di questo genere, la programmazione, la condivisione sono fondamentali. Oggettivamente l’approccio culturale è purtroppo ancora lontano: a Viterbo dove ho creato una area omogenea di chirurgia i tre Direttori di unità operativa che condividono l’area hanno preteso tre Coordinatori per continuare a fare tre visite separate. Siamo purtroppo ancora un po’ lontani dalla condivisione di questa filosofia.
Dott. Ferdinando Romano: il contesto è quello di un grande Policlinico con una grossa componente dominante della Università Sapienza, quindi questo costituisce un contesto particolare, e su questo poi ritorneremo, perché la realtà universitaria che fa la ricerca come attività regolata dalle specialità confligge con il concetto della intensità di cura. La matrice organizzativa dell’ospedale per intensità di cura determina dei sicuri vantaggi su cui non si discute: l’efficientamento dell’utilizzo dei posti letto e delle risorse umane, la qualità della cura. Già la sola valutazione multidimensionale al momento dell’accesso in Pronto Soccorso (PS) è un cardine fondamentale per una valutazione più qualificata; oggi il paziente è assegnato ad un reparto a seconda della patologia o dell’organo principalmente implicato, ma manca tutta una serie di valutazioni correlate comunque allo stato complessivo del paziente, come la fragilità, che possono essere determinanti per stabilire il livello assistenziale e che permetterebbero già in PS di stabilire un percorso definito nei contenuti. Nel Policlinico Umberto I ci sono ostacoli strutturali e logistici importanti, poiché si estende su 100.000 mq coperti ed è composto da 54 padiglioni costruiti in epoche diverse e quindi con superfici disponibili in estensione lineare relativamente piccole: c’è quindi un grosso problema di spazi per poter aggregare i posti letto, ma anche un problema di personale, che per far funzionare il modello deve essere numericamente e professionalmente adeguato, altrimenti non è pensabile alcuna integrazione. Se non ci sono le risorse necessarie, sia strutturali che di personale, invece di creare un efficentamento del sistema si rischia di avere un livello maggiore di inefficienze. Un ulteriore problema è l’integrazione tra le componenti professionali nel contesto specifico in cui va considerata anche la componente universitaria.
Dott. Antonino Cartabellotta: quando parliamo di intensità di cura, non ci riferiamo alla gravità del paziente o alla sua complessità assistenziale, ma ci riferiamo al setting assistenziale a cui viene assegnato il paziente a seguito della valutazione multiprofessionale di due elementi: da un lato la instabilità clinica, erroneamente indicata come gravità clinica, ma che si riferisce alla possibilità che nel corso del ricovero il paziente possa subire un peggioramento anche fino all’exitus e che è una valutazione di competenza del medico in base a degli score standardizzati di gravità (Early Warning Scoring System); dall’altro la complessità assistenziale che ne definisce i bisogni assistenziali determinati dal grado di autosufficienza e che è di competenza infermieristica. Al momento tuttavia da questa valutazione sono escluse due determinanti, la valutazione dei fattori sociali e la valutazione delle comorbidità: entrambe non sono misurabili con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Questo comporta una serie di ostacoli strutturali, tecnologici, organizzativi, ma anche di tipo professionale che non permettono una corretta assegnazione del paziente dal PS al giusto livello assistenziale: stiamo passando da una valutazione fondata sulla patologia d’organo ad una valutazione fondata sulla intensità di cura in base alla instabilità clinica e alla complessità assistenziale. Non vi è dubbio che pazienti instabili dal punto di vista clinico e con elevata complessità assistenziale, così come pazienti instabili ma con bassa complessità assistenziale debbano essere ricoverati rispettivamente in aree critiche ad alta intensità o in aree per acuti; il problema sorge nelle situazioni di bassa instabilità clinica e bassa intensità assistenziale o nelle pluripatologie stabilizzate degli anziani che dovrebbero trovare risposta in un setting territoriale.In sintesi dunque il concetto di instabilità clinica dipende dal quadro clinico del paziente, ed è una valutazione prettamente medica; il concetto di complessità assistenziale è legato ai bisogni del paziente ed è una valutazione prettamente infermieristica; il concetto di intensità di cura è legato all’offerta di servizi e prestazioni sanitarie che la struttura è in grado di erogare.
2. Quali ostacoli (strutturali, organizzativi, tecnologici, professionali) si frappongono alla riorganizzazione dell’OIC? Ci sono fattori facilitanti che la favoriscono?
Dott.ssa Daniela Donetti: mi pare che i maggiori ostacoli siano già stati individuati, almeno in due macro categorie costituite dalla organizzazione dei servizi e dalla necessità di un cambiamento culturale. In una disamina più sistematica elencherei in ordine prima gli ostacoli di tipo organizzativo e culturale, poi quelli di tipo strutturale, poi la necessità di investire risorse e la difficoltà di integrazione con il territorio. Quest’ultimo aspetto è importante soprattutto per le Aziende Ospedaliere che devono mettere in atto idonei meccanismi di integrazione e contrattazione con il territorio affinché sia garantita l’assistenza a bassa intensità, liberando l’ospedale da questo livello assistenziale inappropriato per la tipologia di struttura. Esaminando le esperienze già fatte in altre regioni, come la Toscana o la Lombardia, ci si rende conto che i modelli organizzativi che hanno dato i migliori risultati sono stati quelli in cui si è investito moltissimo nella informatizzazione della comunicazione tra i team di valutazione multidimensionale; il modello di valutazione multidimensionale era in queste realtà già consolidato, la carta vincente è stata renderlo integrato e fruibile da tutti gli utilizzatori attraverso la rete di comunicazione. Ciascuno per le proprie competenze e per il proprio ruolo professionale accede allo stesso network di schede di valutazione, di cartelle cliniche integrate, di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi. Se non siamo capaci di investire in questo aspetto organizzativo, questo sarà l’ostacolo più importante perché non permette di superare la conflittualità. Si tratta di un approccio culturale: se non si capisce che la valutazione e la gestione multidimensionale costituiscono un vantaggio per tutti, per la sicurezza del paziente ma anche per la sicurezza degli operatori, questo sarà l’ostacolo maggiore. Nel momento in cui invece si condividono protocolli e processi, abbiamo la certezza che anche il livello di contenzioso si riduce.
Dott. Ferdinando Romano: intanto parlare di ostacoli non significa necessariamente andare in controtendenza rispetto a qualcosa che comunque si condivide. Nella realtà del Policlinico Umberto I la componente universitaria ha compiti di didattica e di ricerca; il corso di studi universitario, cambiato molte volte negli anni, è però ancora organizzato per discipline apparato d’organo specifiche, e a questo i docenti devono uniformarsi. In parallelo c’è tuttora una organizzazione obsoleta della assistenza ospedaliera organizzata anch’essa in unità operative organo specifiche. Abbiamo quindi una matrice bidimensionale: da un lato le linee formative e dall’altro le linee organizzative, difficili da riconciliare. Riconciliare una funzione disallineata rispetto alla formativa che è allineata rispetto alla funzione assistenziale nell’attuale contesto ma è disallineata rispetto alla funzione assistenziale che segue un modello diverso, costituisce la prima criticità, che va comunque affrontata e risolta. Ma proporre un modello organizzativo che concili i due aspetti è tutt’altro che semplice, e in questo che rappresenta un radicale cambiamento culturale bisogna fare un minimo di funzione propositiva. Dovremmo avere delle linee didattiche che seguono trasversalmente le linee di processo organizzativo della componente multidisciplinare che segue il paziente. Il sistema formativo accademico non è più proponibile così, deve allinearsi a quello organizzativo. La qualità della assistenza in un modello organizzativo che privilegia la valutazione multidimensionale del paziente e la valutazione dei suoi bisogni deve essere la nostra linea guida rispetto a tutto quello che ruota intorno alla attività assistenziale. La formazione e didattica devono quindi rimodularsi in funzione di queste esigenze attuali.
Dott. Antonio D’Urso: dico subito che non sono d’accordo nel considerare il problema strutturale un “ostacolo che si frappone” alla realizzazione dell’ospedale per intensità di cura, perché frapporre significa rendere impossibile! E’ un errore metodologico. Esiste un motivo di fondo: se la riorganizzazione strutturale è considerata una premessa indispensabile alla realizzazione del modello, allora ne riparliamo quando, fra trent’anni forse, avremo ristrutturato il parco dei nostri ospedali, ma nel frattempo non saremo in grado di dare risposte adeguate ai nostri pazienti. Se così non è, e così ritengo che sia anche in base alla mia esperienza in Toscana, è chiaro che un ospedale progettato secondo i criteri della intensità di cura facilita molto il compito. Il problema è l’applicazione del modello di cui stiamo parlando in una realtà ospedaliera, come quella in cui sono ora, costruita a padiglioni. Racconterò la mia esperienza in Toscana, dove c’era un nuovo ospedale in costruzione secondo i principi architettonici della intensità di cura e un vecchio ospedale a padiglioni con poche specialità. Il corpo dei professionisti aveva studiato molto, perché in Toscana dal 2002 si parlava di ospedali per intensità di cura, per cui si era fatto tutto un percorso di preparazione teorica sull’argomento, si erano maturati valori, i professionisti avevano imparato a memoria le diapositive del dott. Cartabellotta e della Nuti, erano però un po’ meno attivi nella pratica. Quindi mi sono posto il problema se aspettare la fine della costruzione dell’ospedale nuovo o cominciare ad applicare il modello organizzativo nell’ospedale vecchio per poi trasferire le attività così riorganizzate nel nuovo; ho scelto la seconda strada. Quando poi abbiamo trasferito in un anno le attività nel nuovo ospedale, il vecchio già funzionava per intensità di cura: ho detto prima che l’intensità di cura è una filosofia e non i dieci comandamenti; quindi nel vecchio ospedale sono stati applicati alcuni principi cardine della intensità di cura, anche perché i professionisti avevano maturato quei concetti di cui parlava la dott.ssa Donetti. Quindi la riorganizzazione strutturale non è un vincolo se i professionisti sono convinti della lettura del modello e non hanno pregiudizi. In Toscana oltretutto è stata fatta una legge regionale in merito, per cui c’era una forte determinazione centrale nella realizzazione. Ci piace dire che il problema è strutturale, ma poi i requisiti strutturali delle stanze di degenza sono uguali nei due modelli, la figura professionale dell’infermiere è equivalente tranne che per il numero dei pazienti che segue, il “medico tutor” oggi, almeno nelle chirurgie, è il medico operatore che continua a seguire il paziente avendo la responsabilità del caso clinico. Quindi direi che i determinanti oggi sono l’aspetto professionale e quello tecnologico infrastrutturale, cioè la cartella clinica condivisa, la disponibilità di software che permettano la visione da parte di tutti di dati di radiologia e di laboratorio, la gestione dei posti letto per l’accoglienza. Se partiamo da un pregiudizio, non applicheremo mai il modello.
Dott. Angelo Tanese: stiamo parlando di una capacità di cambiamento dei nostri ospedali, essendo consapevoli che è sempre difficile cambiare le abitudini e più facile rimanere nei vecchi schemi. Non c’è la certezza che si debba lavorare secondo un modello prestampato e dall’altra parte c’è il mondo dei professionisti che resiste, perché la capacità di cambiamento di una realtà ospedaliera è data dalla capacità di sperimentare cose nuove con i professionisti. Dobbiamo essere consapevoli che i nostri ospedali, pur in un modello tradizionale, negli ultimi venti anni sono stati luoghi di innovazione e di recupero di efficienza straordinarie: quindici anni fa si stava in ospedale una settimana per una cataratta o quattro giorni per una frattura dell’ulna, oggi abbiamo ospedali più efficienti, più sicuri e dinamici, con un livello di innovazione tecnologica e di standardizzazione molto più alto. Oggi però il vecchio modello non funziona più, non garantisce più livelli di qualità ed efficienza adeguati. Siamo arrivati ad una svolta che mette in discussione il modello organizzativo dell’ospedale verso un modello più evoluto di organizzazione sul quale mi sembra siamo tutti d’accordo. Non è più pensabile che vi sia una rigidità nel modo di funzionare; è chiaro che quando abbiamo vincoli strutturali dettati dalla vetustà delle strutture, può essere più difficile, forse in alcune situazioni con ospedali che hanno più di cento anni è inutile accanirsi e sarebbe meglio costruire un ospedale nuovo: in altri paesi si costruiscono ospedali in tre anni! Queste sono scelte che vanno fatte. In ogni caso è un cambiamento organizzativo e anche culturale, ma a volte la cultura cambia perché si sperimentano nuovi modi di lavorare, non è detto che debba avvenire prima il cambiamento culturale. Si tratta di avere una gestione complessivamente più flessibile: la gestione del posto letto non può essere ricondotta alla autonomia del singolo reparto, la valutazione della intensità assistenziale richiede un ruolo principale dell’infermiere di cui ormai dobbiamo prendere atto. Quindi un approccio meno ideologico e meno rigido. Sicuramente un adeguamento strutturale è il momento buono per un cambiamento organizzativo, come sta avvenendo al San Filippo dove si sono inaugurate nuove aree ristrutturate. Non mi porrei però il problema in senso dicotomico, ospedale per intensità di cura sì o no, quanto mi preoccuperei dei singoli aspetti che possono essere applicati anche a singoli percorsi, tipo l’accoglienza del paziente, la distinzione dei percorsi chirurgici. E’ il momento di trovare soluzioni nuove, anche con scelte difficili che possono costare in termini economici, ma che poi a lungo termine producono sicuramente vantaggi. Abbiamo anche bisogno di una iniezione di forze nuove, se non altro in senso anagrafico: a chi lavora da tanti anni non si possono chiedere ulteriori cambiamenti. E’ anche determinante considerare l’organizzazione dell’ospedale come identità unica, una unica squadra, e non far prevalere l’organizzazione delle tante singole entità che lo compongono.
Dott. Antonino Cartabellotta: la riorganizzazione dell’ospedale secondo il modello per intensità di cura deve tenere conto di quello che il territorio è in grado di offrire. Quando si parla di “assistenza sanitaria per intensità di cura” si presuppone la riorganizzazione in tal senso anche dell’assistenza territoriale, con l’uso di percorsi che necessariamente nella maggior parte dei casi sono interaziendali, favorendo l’integrazione tra ospedale e territorio. D’altra parte se è vero che buona parte delle risorse del SSN viene impiegata impropriamente in quello che si chiama inadeguato coordinamento della assistenza, se lavoriamo solo sulla riorganizzazione degli ospedali recuperiamo solo una parte delle risorse, ma se applichiamo lo stesso principio e lavoriamo sulla integrazione ospedale/territorio forse recuperiamo una fetta maggiore di risorse da riallocare. Quindi è più logico parlare di una riorganizzazione integrata della assistenza per intensità di cura. La riorganizzazione del territorio deve prevedere una variabile articolazione di setting assistenziali, quali l’hospice, l’assistenza domiciliare integrata, il servizio sociale; se questi non ci sono o non funzionano il paziente rimane o rientra in ospedale in modo inappropriato. Oggi le malattie croniche non trasmissibili rappresentano il carico assistenziale maggiore per il SSN, tutto quello che si identifica con la transitional care, cioè la gestione del passaggio dalla acuzie alla cronicità, necessita di attenzione maggiore. In questo senso un’Azienda Ospedaliera o un’Azienda Sanitaria possono avere problematiche diverse di integrazione con il territorio.
3. La riorganizzazione dell’ospedale per intensità di cura è inevitabilmente condizionata dall’offerta dei servizi territoriali, che identificano il concetto più ampio di “assistenza per intensità di cura”. Ma la riorganizzazione integrata tra ospedale e cure primarie è solo un problema di risorse?
Dott. Ferdinando Romano: dalla legge Balduzzi in poi le UCCP rappresentano l’unità organizzativa base, lo snodo della assistenza territoriale da cui si inizia a garantire la presa in carico multidisciplinare del paziente. Ogni UCCP aggrega al massimo 30.000 abitanti con un minimo di 20 medici di famiglia; questa tipologia di organizzazione è in perfetta simmetria con l’organizzazione ospedaliera. In questo modo c’è una circolarità centrata sulla assistenza al paziente e non una dicotomia ospedale/territorio. L’ospedalizzazione a domicilio è oggi una organizzazione complessa della estensione della assistenza ospedaliera sul territorio: bisogna capire se è l’ospedalizzazione che prevale sul concetto di domiciliarità o la domiciliarità che prevale sul concetto di ospedalizzazione, e di chi è la competenza, se stiamo allungando o meno le propaggini dell’ospedale sul territorio. C’è una realtà importantissima prevista nella legislazione: le RSA hanno una loro collocazione, così come l’hospice che ha una funzione specifica confinata ai malati terminali oncologici, c’è l’assistenza sociale, ma c’è anche l’Ospedale di Comunità, setting assistenziale territoriale che corrisponde alla bassa intensità assistenziale, il vero grande polmone per l’ospedale e per la società per i pazienti che non possono essere assistiti a domicilio su cui la sanità dovrebbe investire riconvertendo i piccoli ospedali. Per essere Ospedale di Comunità, quindi posto letto territoriale, non va ad intaccare lo standard dei posti letto ospedalieri per acuti, assicura assistenza infermieristica h. 24 e medica h 12, continuità assistenziale notturna, accesso a tutti i servizi, con costi del posto letto territoriale come lungodegenza, quindi contenuti. Questo consente la realizzazione della assistenza territoriale qualificata soprattutto nelle situazioni di disagio o di oneri troppo elevati per le famiglie.
Dott. Antonio D’Urso: questo ragionamento non c’entra nulla con l’organizzazione dell’ospedale per intensità di cura. Io non credo che l’ospedale per intensità di cura funziona se il territorio è organizzato per intensità di cura. Dico che un ospedale moderno funziona, qualunque sia il modello organizzativo, se il territorio funziona. I nostri ospedali nella aree mediche, non organizzate per intensità di cura, hanno degenze piuttosto elevate; gli ospedali di comunità servono sia all’ospedale modello legge Petragnani sia all’ospedale per intensità di cura. Noi dobbiamo avere sempre lo stesso standard di posti letto per abitanti. Spostare la bassa intensità dall’ospedale al territorio, qualunque terminologia vogliamo dare a queste strutture territoriali, è una esigenza ineludibile, indipendentemente dalla intensità di cure; forse è più urgente lavorare su questo anche perché obiettivamente più complesso, perché al contrario applicare alcuni aspetti della intensità di cura in ospedale, soprattutto per l’area chirurgica separando elezione e urgenza o centralizzando la preospedalizzazione, è di una semplicità straordinaria, è solo un problema di organizzazione.
Dott.ssa Daniela Donetti: io sono meno ospedalocentrica. Possiamo parlare di intensità di cura anche sul territorio: uno dei principi è la presa in carico del cittadino per soddisfare i bisogni di salute, e Il territorio è il luogo in cui deve avvenire la presa in carico del cittadino rispondendo ai suoi bisogni globali. Questo è un concetto importante perché introduce degli strumenti già introdotti nella intensità di cura dell’ospedale, lasciando fattori sociali e comorbidità al territorio, in cui invece questi elementi pesano moltissimo. Nel territorio ci sono gli strumenti per gestire questi aspetti: le “unità di valutazione multidimensionale territoriali” usano delle scale specifiche per valutate i bisogni sociali, vengono predisposti piani assistenziali individuali secondo un concetto di personalizzazione della cura, logica che dovrebbe essere inserita anche nell’ospedale per intensità di cure: il medico tutor è quello che segue il paziente non solo dal punto di vista clinico; molti pazienti vengono gestiti secondo percorsi diagnostico-terapeutici. Quello che manca nel territorio è la costante rivalutazione del paziente per evitare che debba accedere nuovamente all’ospedale: il territorio non funziona quando non riesce a controllare le riacutizzazioni delle patologie o quando non riesce a gestire nelle proprie strutture territoriali il paziente. Quindi chi lavora in una ASL deve cercare di sviluppare questi processi organizzativi per fare in modo che sia attuata la continua rivalutazione, che possono avere anche una ricaduta economica positiva, ma soprattutto rispondono ai bisogni assistenziali del cittadino.
Dott. Angelo Tanese: io non ho nessun tipo di risposta! Dal punto di vista della Azienda Sanitaria il tema è centrale, la ASL Roma 1 ha circa 7.000 posti letto per un milione di abitanti e decine di strutture territoriali che erogano varia tipologia di prestazioni, oltre ad alcune strutture private accreditate. La domanda non riguarda la riorganizzazione dell’ospedale, ma dovremmo avere la capacità di riorganizzare anche le strutture del territorio in modo più evoluto. Forse è il concetto di separazione ospedale/territorio deve cambiare: il SSN di cui giustamente ci vantiamo deve fare il salto di non ragionare sulla sommatoria di singole strutture separate e autonome che cercano di creare collegamenti in tentativi che vanno ripensati ogni volta o che si basano su isolate iniziative, ma bisogna pensare a una organizzazione “di sistema”. Da questo punto di vista nessuna Azienda Ospedaliera è separata dal territorio, nessun Ospedale o Azienda Ospedaliera può prescindere dalle strutture territoriali o viceversa; se le Aziende Ospedaliere erogano fino al 50-70 % delle prestazioni ai propri residenti, è evidente che debbano essere integrate. Dobbiamo mettere in atto una capacità organizzativa superiore che metta in campo tutte le capacità organizzative delle strutture per una maggiore integrazione. Come fare questo: così come in un ospedale nessuna unità operativa deve sentirsi autonoma rispetto ad un disegno più ampio dell’Ospedale o della Azienda Ospedaliera in cui è inserita, così ogni struttura organizzativa ospedaliera o territoriale deve sentirsi parte e integrarsi in una organizzazione più ampia che opera per soddisfare i bisogni di salute del cittadino. Questo fa la differenza perché significa mettere in campo tutte le proprie risorse; non è un primato di uno o di un altro; dobbiamo essere in grado di dare una risposta integrata usando al meglio quello che abbiamo, con un sicuro ritorno in termini di efficienza e di recupero di risorse.
Dott.ssa Flori Degrassi: “Il caso dell’Ospedale Pertini di Roma”
Nella mia esperienza lavorativa nel 2002 ero in Toscana, nella Azienda territoriale di Pisa, con l’assessore Rossi che ora è Presidente della regione Toscana ed che era stato sindaco di Pontedera. L’Azienda territoriale di Pisa comprendeva due ospedali, Pontedera e Volterra; si pensò di fare la sperimentazione della intensità di cura e quindi passai tutto il 2002 ad organizzare l’ospedale per intensità di cure a Pontedera. Ho riorganizzato l’area chirurgica, non quella medica, e tuttora l’ospedale di Pontedera funziona per intensità di cure, come è stato riorganizzato allora. Sono d’accordo con il dott. D’Urso che la riorganizzazione dell’area chirurgica di un ospedale è molto facile.
Non lo chiamerei più neanche io ospedale per intensità di cura, non so più quale sia il significato, penso che gli ospedali vadano sicuramente riorganizzati in modo diverso dall’attuale. Come ha detto prima il dott. Tanese abbiamo fatto rilevanti progressi in campo tecnologico che hanno cambiato radicalmente il modo di fare diagnosi e terapia: una volta si facevano interventi tipo Billroth 1 e 2 per l’ulcera, ora si fa terapia medica e non più chirurgica, è arrivata la laparoscopia e l’urologia è cambiata, è arrivata la robotica e si sono fatti altri progressi. Ma soprattutto si è evoluta la terapia medica in modo drammatico, per cui è cambiato radicalmente il modo di fare salute.
A questi cambiamenti non ha corrisposto un cambiamento organizzativo degli ospedali, che sono quelli di 20 anni fa, tali e quali. Se una procedura si può fare in Day Surgery, perché non usare una piattaforma tutta dedicata a questa attività che chiude sempre la notte, il sabato pomeriggio e la domenica con personale dedicato. Perché non organizzare la degenza chirurgica in modo da raggruppare interventi la cui degenza dura 2, 3, 4 o 5 giorni in modo da chiudere l’area di degenza il venerdì notte, il sabato e la domenica. Ci sono ospedali medici oncologici in Svizzera che lavorano in week da 30 anni. Abbiamo avuto un cambio radicale nella modalità di curare le persone, ma non abbiamo organizzato piattaforme per erogare l’assistenza perché “abbiamo fatto sempre così”. Quello di cui le Aziende sono ricche è il patrimonio culturale di tutti i professionisti della sanità, perché tutti portano nella organizzazione il loro patrimonio di conoscenza, ma non abbiamo saputo organizzare questo patrimonio culturale per rendere efficiente l’organizzazione, dando per scontato che sia efficace. In un sistema così povero di risorse, come quello sanitario, l’unica cosa da fare è rompere la routine e creare alternative organizzative e organizzative/strutturali, modi di pensare l’organizzazione o meglio il modo in cui il professionista si affida all’organizzazione che gli rende più facile la sua attività clinica sul paziente, perché diventi più efficiente. Ci dovrebbe essere un atto di fiducia dei professionisti medici nei confronti della struttura organizzativa, per poter avere a disposizione la piattaforma assistenziale con la migliore tecnologia, le migliori competenze al fine di dare un miglior servizio al paziente che in quel momento è il suo paziente.
Partendo dal presupposto che l’ospedale cura l’acuzie e il territorio si prende carico della cronicità, vediamo di ragionare su quella che è l’acuzie vera, cioè il Pronto Soccorso (PS). Ma chi ha detto che il PS deve sempre ricoverare: in una organizzazione così complessa come quella di cui stiamo parlando, si deve mettere in gioco anche il PS, nel senso che il PS deve sapere anche mandare a casa, o meglio differire il ricovero anche se necessario ma non urgente. Mi spiego meglio: il modello per intensità di cura deve essere applicato anche se il paziente che vi arriva è candidabile al ricovero ma questo può essere differito e spostato: all’ambulatorio, al Day Hospital, al Day Service o ad altre forme assistenziali. Entra in ospedale solo il paziente che ha bisogno di ricovero perché è in una fase acuta di malattia. Se non partiamo dalla messa in discussione totale dell’ospedale, compresa l’organizzazione dei servizi come la Radiologia, che oltre ad essere funzionale all’urgenza, può essere organizzata per tutto quello che serve per i pazienti candidabili al ricovero quel giorno o quella settimana. Bisogna però togliere tutte le “variabilità” del sistema attuale; una volta ad esempio ai pazienti che si ricoveravano, qualunque fosse la patologia, si facevano lunghe liste di esami di routine già predisposti, a cui si aggiungevano quelli che prima l’aiuto anziano e poi il primario richiedevano, per cui per interventi che oggi si fanno in “one day surgery” si avevano degenze anche di venti giorni, e tutti erano contenti. Ma non erano contenti i pazienti, né i professionisti che non potevano essere gratificati vedendo sempre lo stesso paziente sullo stesso letto per venti giorni! Con il numero di posti letto che oggi abbiamo è impensabile gestire così i ricoveri. Quindi partendo dal presupposto che una Azienda territoriale deve organizzare i percorsi assistenziali, il che di fatto è una riorganizzazione per processi, c’è lo stesso filo conduttore che lega l’ospedale e il territorio. Noi che abbiamo la fortuna di partire con due percorsi diagnostico terapeutici, BPCO e diabete, vedremo come fare.
Nel Pertini abbiamo impegnato gli anni 2006 e 2007 a riorganizzare l’area chirurgica. Le attività ambulatoriali sono state portate tutte fuori dell’ospedale, in zona separata Day surgery, week surgery e long separate. Poi verso la fine del mandato, 2008 e 2009, siamo passati all’area medica che è stata organizzata in modo molto sofisticato per nuclei assistenziali anche visivamente distinti: lo scompenso aveva una stanza colorata in rosso, il diabete un altro colore; ogni nucleo aveva un tutor medico e un infermiere responsabile del nucleo e del caso clinico. E’ stato applicato questo modello più complesso rispetto all’altro distinto in week e long su richiesta dei medici. Quando è cambiata la Direzione, il modello si è interrotto drasticamente. Quindi tornata al Pertini dopo sei anni, non funzionava più niente della organizzazione precedente tranne per le specialità chirurgiche che continuavano a comportarsi come se ci fosse la week surgery; i professionisti l’avevano acquisita come loro modalità operativa mentre per gli altri si erano ricostruite le barriere tra i reparti. Però per quanto nel Lazio allora fossimo i primi insieme al Santo Spirito ad aver fatto un esperimento per intensità di cura, non avevamo avuto il coraggio di applicare il modello fino in fondo, perché nell’area chirurgica non erano entrate l’ortopedia, la neurochirurgia, la ginecologia e nell’area medica la cardiologia e la nefrologia. Al mio rientro è ricominciato il modello per intensità di cure per l’area chirurgica che comprende anche ortopedia e a breve ginecologia; per l’area medica il modello è semplificato, avendo purtroppo perso quel bagaglio di esperienza, con DH e degenza week e long, partendo dal presupposto che sia i pazienti in elezione, pochissimi al Pertini in area medica dove il PS ha una affluenza drammatica, sia in PS si può applicare il modello per intensità di cura. Nell’atto aziendale invece dei dipartimenti sono state fatte le “aree per intensità di cura” per creare la cultura. Perché questa organizzazione funzioni è indispensabile che ci creda la direzione strategica e che i professionisti vengano coinvolti nella analisi dei processi e delle criticità.
Il Pertini è a un ospedale costruito a piastra, il Sant’Eugenio è una parte a piastra e una parte edificio di dodici piani con moduli di 19-20 posti letto per piano. E’ chiaro che la struttura condiziona l’organizzazione. Intanto tutti gli ospedali hanno un’anima e sono tutti diversi tra di loro, quindi bisogna cercare di capire prima qual è l’anima dell’ospedale e poi come correggere l’organizzazione dell’ospedale.
Quello che volevo dire prima: nelle ASL siamo chiamati a valutare quello che è ospedale e quello che è territorio; se noi riusciamo a spostare il valore economico delle attività ambulatoriali fatte in ospedale, che sono invece di competenza territoriale, o se riusciamo a spostare a livello territoriale tutte quelle attività di quelle unità operative specialistiche quali la diabetologia, l’endocrinologia, la broncopneumologia ce la faremo, ma dobbiamo far capire agli ospedalieri che, quando fanno quelle attività, stanno lavorando per il territorio. Sarà più facile per le Aziende territoriali, ma sarà più difficile per le Aziende Ospedaliere. Quando si fanno controlli ambulatoriali in ospedale si rimane a vita sotto controllo dell’ospedale; ad esempio un ospedale oncologico non limita il periodo di controllo dei pazienti a cinque anni, si entra nella catena di montaggio e si fanno follow-up a vita, non si esce mai, per cui non c’è mai spazio per far entrare pazienti nuovi. Il follow-up intensivo dovrebbe essere limitato al periodo necessario ma il controllo successivo dovrebbe passare al territorio fino ad eventuali riacutizzazioni. Anche per gli ospedalieri non monospecialistici il discorso è lo stesso: devono seguire il paziente solo nella fase acuta, poi lo devono lasciare andare sul territorio, altrimenti noi intaseremo sempre l’acuzie e il sistema non potrà funzionare.